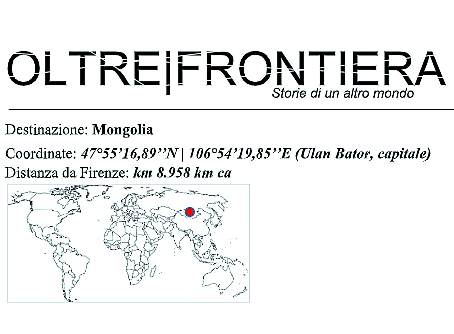
Nessuno parla mai della Mongolia. Perché se ne dovrebbe parlare, del resto? Questo paese grande cinque volte l’Italia, incastrato tra la Russia siberiana e la Cina desertica, è uno sterminato luogo del niente. È uno di quei posti che accendono la fantasia di noi occidentali; dove puoi vedere due condor che spolpano la carcassa di un animale sul ciglio della strada, e in lontananza una mandria di cavalli allo strato brado, che galoppano, sollevando una nuvola di polvere alle loro spalle.
Con una media di 1,94 abitanti per chilometro quadrato, è il quarto paese meno densamente popolato del mondo. Se si ha l’ardire di spingersi all’interno, si può viaggiare per giorni senza vedere anima viva. Senza sbocchi sul mare, con solo lo 0,6 percento di territorio con risorse idriche, la Mongolia è un gigante geografico inospitale e quasi del tutto inabitabile. Quasi.
Anche dal punto di vista politico questo sconfinato paese è un posto unico al mondo. Pur schiacciata da Cina e Russia, la Mongolia è una tranquilla democrazia semipresidenziale, senza tensioni politiche di sorta, che ha abbracciato il capitalismo alla caduta dell’Unione Sovietica, e che non è al centro di alcuna istanza revanscista da parte di nessuna delle due superpotenze comuniste.
Eppure, nessuno parla mai della Mongolia. Non se ne è parlato abbastanza neanche quando, nel marzo del 2021, si è abbattuta sul paese una tempesta senza precedenti. E dire che da queste parti ci sono abituati alle tempeste. La lingua mongola, infatti, prevede due parole specifiche per questo tipo di evento atmosferico, tanto è frequente: lo “dzud” bianco, che sarebbe la tempesta invernale che ricopre di neve tutto il paese e che fa scendere il termometro fino meno 40 gradi, e lo “dzud” nero, cioè la tempesta di sabbia e polvere, tipica dei mesi primaverile e autunnali, che oscura il cielo come se fosse notte fonda. Lo “dzud” nero di due anni fa ha martoriato valli e altipiani della Mongolia per diciotto ore filate. Cinquecentonovanta persone, tutti pastori nomadi, sono letteralmente scomparse nel nulla. Una fine ancor peggiore l’hanno fatto i loro animali, scaraventati a terra dal vento, e sepolti vivi sotto più di un metro di terra, sabbia e sassi: solo le zampe inteccherite spuntavano sinistramente dal suolo, come croci incompiute di un cimitero improvvisato.
L’allevamento di pecore e capre è il settore economico principale in Mongolia. A portarlo avanti sono i pastori nomadi, che rappresentano circa il 30 per cento della popolazione. La costituzione del paese dà loro la possibilità di piantare la propria “ger”, la grande tenda dove vive tutto il nucleo familiare, e far pascolare il proprio gregge, ovunque essi vogliano. Si spostano in base alle stagioni, ma il cambiamento climatico e l’abbandono delle politiche socialiste di controllo del numero di capi che ogni pastore poteva avere, sta mettendo a rischio questo antico modo di vivere. La catastrofica tempesta del 2021, ha provocato la morte di un numero enorme di animali e ha dato un durissimo colpo al settore. Centinaia e centinaia di pastori che avevano perso tutto, si sono riversati nei dintorni della capitale, dando vita ad una sorta di tendopoli, nella speranza di trovare lavoro in città, o di riuscire a ricostruire un nuovo gregge e ripartire verso le sconfinate zone interne.
Ma l’intensificazione della violenza delle tempeste, causata da un innaturale innalzamento della temperatura di ben 2,4 gradi a partire dal 1960, non è la sola conseguenza della crisi climatica: la crescente desertificazione del territorio, unita all’aumento della siccità del clima, riducono i terreni pascolabili e soprattutto li impoveriscono. C’è un motivo per cui la pastorizia è l’attività economica principale del paese da sempre. Fino al 1990, le valli e gli altopiani della Mongolia erano ricoperte di erba altissima, una sorta di mare verde che ondeggiava al vento: una risorsa praticamente illimitata per allevare le pecore e soprattutto le capre Hircus, da cui si ricava la preziosa lana Cashmere. Durante il periodo comunista, ogni famiglia di pastori aveva diritto a un numero massimo di 75 capi, lo Stato erogava uno stipendio per il latte e la lana prodotti, assicurava cure veterinarie per gli animali e la sostituzione di ogni animale morto per catastrofe naturale. Un sistema che molti pastori rimpiangono, perché se è vero che dopo il crollo dell’URSS e il passaggio ad un’economia capitalista, questi ultimi hanno potuto incrementare a loro piacimento i greggi, prosperando grazie ai ricavi ottenuti dalla vendita diretta del latte e della lana, è altrettanto vero che il numero di animali è aumentato vertiginosamente fino a raggiungere gli attuali 90 milioni di capi. L’erba che prima arrivava alle ginocchia e rendeva difficile camminarci in mezzo, adesso cresce fragile e a piccoli ciuffi. Le capre che producono la lana cashmere, sono galline dalle uova d’oro ma sradicando l’intera zolla, anziché limitarsi a brucarla, danneggiano gravemente il territorio. La crisi climatica decima ogni anno i greggi, così i pastori sono portati a comprare più animali per fare fronte alle emergenze; ma il loro sovrannumero determina a sua volta un danno ambientale. È un circolo vizioso che porterà in poche decine di anni alla completa desertificazione della Mongolia.
Neanche la rigida dottrina socialista è riuscita ad industrializzare l’allevamento nel paese. Come abbiamo visto, la sua applicazione si era dovuta adattare alla vocazione e alle tradizioni di queste popolazioni. Così, ancora oggi, si possono vedere pastori che governano i loro greggi a cavallo o in sella ad una moto, nel caso di mandrie particolarmente grandi. Se c’è un capo da macellare, lo prendono con il lazo e lo immobilizzano a terra; poi, con un gesto rapido ed esperto del coltello, praticano un taglio nel ventre dell’animale, vi infilano il braccio dentro e strappano via il nervo principale: l’animale muore non sentendo praticamente niente. Una morte rapida e rispettosa, così viene descritta. Le donne invece si dedicano a sradicare le centinaia di vermi che sia annidano nelle piccole ferite delle spesse code di capre e pecore, affinché le stesse non s’infettino e l’animale muoia. Lo fanno a mano, con una pinzetta, verme dopo verme, ogni giorno, tutti i giorni dell’anno. Al tramonto i pastori fanno ritorno nelle loro tende, piantate lì, in mezzo al nulla, con le montagne scure tutte intorno, che sembrano irraggiungibili. Il passaggio di qualche straniero è un evento talmente raro, che ne viene tramandato il ricordo per un paio di generazioni, almeno. Nel migliore dei casi, la famiglia più vicina dista qualche decina di chilometri, quindi ritrovarsi la sera in veranda, con una birra ghiacciata in mano, a parlare del più e del meno con il dirimpettaio, è un piacere che, da queste parte, non si può assaporare. Inutile dire che le zone centrali della Mongolia non hanno copertura mobile, ma alcune “ger” sono collegate tra di loro con una linea fissa, e quindi un minimo di interazione sociale, al di là della propria famiglia, è possibile. E poi, naturalmente, c’è la televisione satellitare, che tiene informate le famiglie sui fatti del mondo. Ma nonostante questi sprazzi di modernità, la vita dei pastori nomadi mongoli è fatta di duro lavoro e solitudine, a stretto contatto con una natura maestosa, selvaggia e sempre più distruttiva. E le tradizioni restano immutate. Le nuove coppie, per esempio, si formano esattamente come si formavano centinaia di anni fa: un giovane pastore conosce una ragazza di un’altra famiglia di pastori e le chiede di sposarlo. Questa cosa può andare avanti per giorni, come finire subito, nel bene e nel male. Non ci sono vincoli familiari, le donne sono libere di scegliere senza dover sottostare a nessun rigido ruolo. Il credo religioso dei nomadi è un misto di buddismo e sciamanesimo. Si bruciano materiali solforosi per tenere lontano gli spiriti maligni, o si passa della fuliggine sul naso di un bambino per onorare la leggenda secondo la quale una madre cosparse il viso del suo bambino di cenere, per far credere ai due demoni che erano apparsi per portarselo via, che suo figlio in realtà era un coniglio. I due demoni abboccarono e da quel giorno si macchia il viso di un bambino per proteggerlo dai pericoli.
Allo stesso tempo i mongoli credono nella positività e nel potere dei buoni propositi di plasmare e migliorare le cose. Ma difronte a quello che sta accadendo al loro mondo, alla loro storia e alla loro terra, questo ottimismo vacilla ogni giorno di più. Fino a quando il fruscio delle alte erbe della Mongolia e le storie dei suoi pastori nomadi non saranno voci lontane portate dal vento.
Fonti: De Groene Amsterdammer (Paesi Bassi, articolo originale); tradotto e pubblicato in Italia da. Internazionale (Italia), Wikipedia

